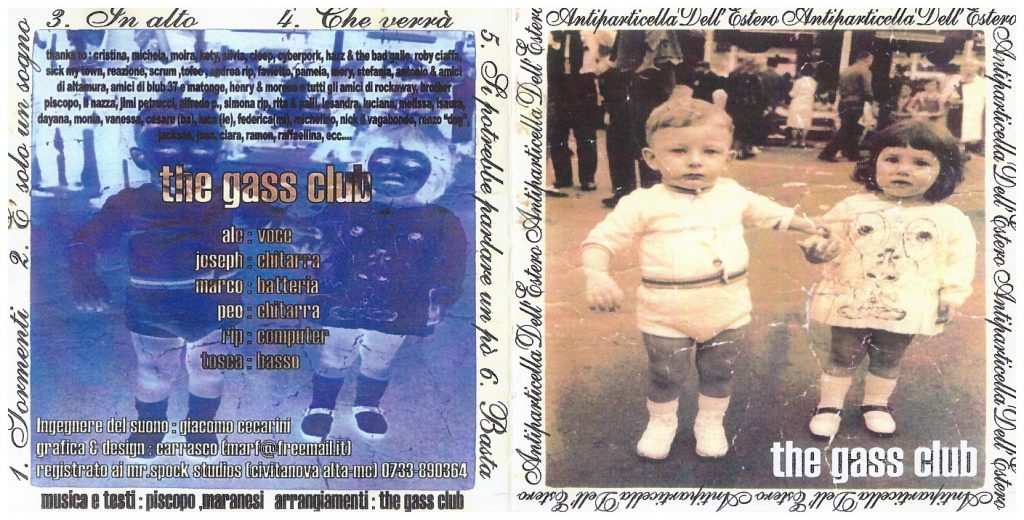Impossessarci delle canzoni che più amiamo è un’operazione quasi naturale, potremmo dire spontanea. Spesso appiccichiamo su di loro un significato del tutto personale, basato sui nostri umori, sul nostro vissuto, sul nostro modo di osservare il mondo che ci circonda. Fino a stravolgerne il significato e poco importa se le intenzioni di chi le ha vergate e musicate andavano in tutt’altra direzione. Dunque, di cosa parla veramente una canzone?
È vero, il titolo dell’opera prima di Raffaele Calvanese non contempla la presenza di un punto interrogativo. Volutamente. Non c’è bisogno di formulare una domanda in tal senso, pertanto, nemmeno di improvvisare una risposta, convincente o meno che fosse. Le canzoni diventano parte di chi le ascolta, si insinuano nella vita di chi le consuma (a volte sino allo sfinimento), giocano un ruolo di identità, di appartenenza. Certo, non le abbiamo scritte noi, anche se ci sarebbe piaciuto, ma, spesso e volentieri, vorremmo essere considerati come protagonisti di quelle storie che tanto ci prendono ed emozionano.
Lo scrittore campano di canzoni se ne intende. Lavora in un’emittente radiofonica da parecchi anni, è autore di programmi e scrive (di musica, va da sé), su alcune riviste on-line. Di che cosa parla veramente una canzone è una raccolta di dieci racconti brevi, alcuni basati sulle esperienze dell’autore, altre frutto della sua fantasia. Tra le pagine del volume prendono forma storie popolate da coppie giunte al capolinea, da ricercatori in fuga dall’Italia, si parla di radio, di innamoramenti, di amici che non ci sono più, di legami familiari, tra ricordi, commozioni, rabbia. Storie accomunate dalla presenza di una serie di brani che giocano una parte attiva all’interno della narrazione, che ne agevolano l’andamento, ne puntellano gli eventi. Calvarese finisce per coinvolgere artisti del calibro degli Smiths, Mao e la Rivoluzione, Colapesce, Pino Daniele, 24 Grana, Daniele Silvestri, Offlaga Disco Pax, Lucio Battisti, I Cani, denotando una malcelata attrazione per la musica di qualità e per il variegato mondo dell’indie rock tricolore.
Di che cosa parla veramente una canzone si affida una scrittura dinamica e colta, fluida e armoniosa, che mai si permette una sia pur piccola pausa. Non solo: i racconti allineati al suo interno finiscono per offrire al lettore un innegabile senso di partecipazione con le vicende narrate, tanto più se il lettore di cui sopra non può fare a meno della musica e del potere taumaturgico delle canzoni.
(da sololibri.net, 12 novembre 2019)