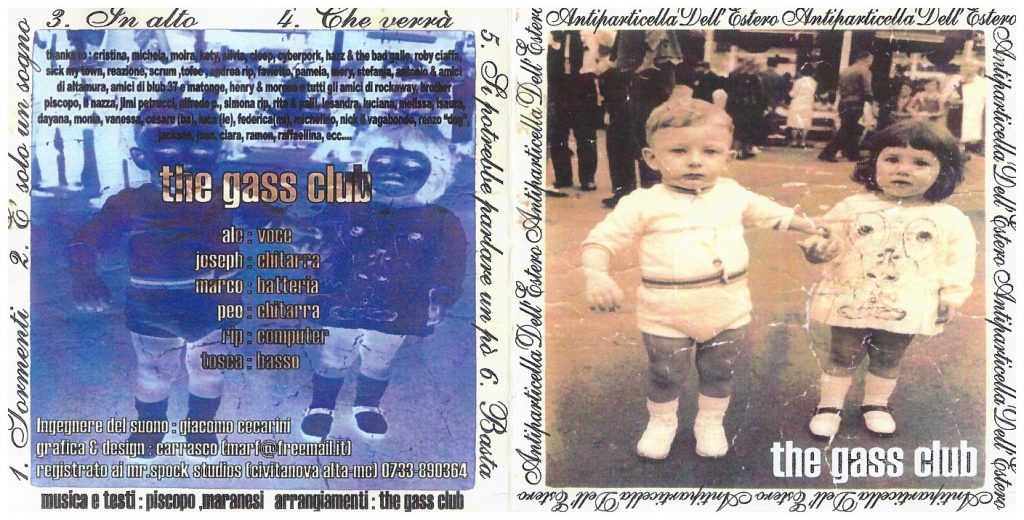Dietro la ragione sociale si muove un duo, costituito da Flavio Fucili e Marco Pesenti. Al loro fianco un gruppo di amici con il compito di regalare sostanza e qualità alle canzoni dei De Rien. Nate e cresciute partendo dal pianoforte, alla ricerca della giusta alchimia tra musica e testi, tra un istinto cantautorale feroce e altre suggestioni che si sono fatte largo senza trovare ostacoli.
“Canzoni profane e d’amor”, secondo la visione dei suoi autori, equivale a otto tele di grandi dimensioni. Scegliere i colori, decidere a quali geometrie affidarsi, non è stato poi così difficile. I De Rien hanno scelto di dipingere storie intrise di malinconia, di sogni, di amore e sentimenti, di romanticismo, di vita, di destini allo sbando, tra ululati alla luna e mucchi di parole in costante agguato. Il percorso seguito è quello della canzone d’autore, ma c’è stato il tempo per percorrere altre strade. Che hanno contaminato le otto canzoni dell’album: riferimento non casuale agli accenni rap di “Semplice”, alla tromba davisiana di “Se fosse diverso”, al tango di “De pe a pa”, senza dimenticare il sapore di Francia che spunta qua e là e qualche spruzzata di elettronica a condensare il tutto. La voce di Marco Pesenti, un ibrido tra Fabrizio De Andrè e Mario Castelnuovo, guida con fare sicuro, la poesia dei testi regala emozioni e piccoli brividi (“Desideri in ostaggio di un domani, come gli occhi di un Modigliani”: bello, no?).
Un esordio positivo e centrato, anche se non sempre gli arrangiamenti sembrano tenere il passo. Ma va bene così, almeno per il momento.
(da rockit.it 6 gennaio 2020)